|
CAPITOLO LXVI SI DETERMINA DON CHISCIOTTE DI FARSI PASTORE, E DI CONDURRE LA VITA TRA LE CAMPAGNE, FINCHÉ SCORRA L'ANNO DI SUA PROMESSA, CON ALTRI AVVENIMENTI PIACEVOLI E GUSTOSI.
Se tanti pensieri tenevano afflitto don Chisciotte prima ch'ei fosse fatto stramazzare, molti più lo tribolavano dopo la sua sconfitta. Stavasene, come si è detto, sotto un albero all'ombra, e quivi come mosche al mele, un'afflizione era da altra raggiunta, ed ora egli pensava al disincanto di Dulcinea, ora alla vita che dovrebbe fare nell'ozio a cui era obbligato. Lo raggiunse Sancio, e gli fece molti elogi della liberalità dello staffiere Tosilo. — Ed è dunque possibile, o Sancio, dissegli don Chisciotte, che ti sii fitto in capo che colui sia vero e reale staffiere? Si vede bene che ti è uscito di mente d'aver veduto Dulcinea convertita e trasformata in contadina, e il cavaliere dagli Specchi nel baccelliere Sansone Carrasco: opere tutte degl'incantatori che mi perseguitano, ma dimmi un poco: chiedesti tu a questo tuo Tosilo che cosa sia accaduto di Altisidora? se pianse per la mia assenza, se ha dati all'oblio gl'innamorati pensieri che, me presente, la tormentavano? — Oh, i pensieri che io aveva in testa, disse Sancio, non mi lasciarono tempo d'informarmi di queste inezie; e poi, per l'anima mia, mi pare, signor mio, che adesso dovrebbe vossignoria occuparsi di altro che d'inezie amorose. — Tu dèi riflettere, o Sancio, rispose don Chisciotte, che corre gran differenza dalle opere che si fanno per amore a quelle che provengono da gratitudine: e può darsi benissimo che un cavaliere sia disamorato; ma, parlando con istretto rigore, egli non può essere mai ingrato e sconoscente. Altisidora, per quanto si è veduto, mi volle bene: mi donò le tre cuffie che tu sai, pianse alla mia partenza, mi maledisse, mi vituperò, e a dispetto del pudore mandò pubblici lamenti: segni tutti che mi adorava; giacché gli sdegni degli amanti sogliono finire in maledizioni. Io non mi sono trovato in caso, né di darle speranze né di offrirle tesori, perché le prime furono da me serbate a Dulcinea, e i tesori dei cavalieri erranti sono come quelli dei folletti, apparenti cioè e fallaci: e mi è permesso unicamente mostrare il pegno che da lei tengo, senza pregiudizio però di quello che mi venne da Dulcinea. Ah, Dulcinea! tu sei il bersaglio delle offese di costui che in vituperevole guisa è sempre restio a volersi frustare e a castigare queste sue carni, che possa io vederle divorate dai lupi, poi che vogliono serbarsi a pascolo dei vermi piuttostoché adoperarsi a conforto di una sventurata! — Signor mio, disse Sancio, se debbo confessare la verità, io non mi posso mettere in testa che le frustate delle mie natiche abbiano che fare con i disincanti degl'incantati: ch'è come si dicesse: Se ti duole il capo, ungiti le ginocchia. Vorrei giurare che in quante storie vossignoria ha letto, e che trattano della cavalleria errante, non si è mai visto alcuno disincantato a prezzo di frustate ma comunque la cosa sia, io mi frusterò quando però me ne verrà la voglia, e ne abbia opportunità. — Lo faccia il Cielo, rispose don Chisciotte, e ti presti egli favore affinché tu ti ravvegga e conosca l'obbligo che ti corre di aiutare la mia signora, ch'è anche tua, perché tu sei mio.» Andavano con questi ragionamenti seguitando il loro viaggio, quando giunsero al sito medesimo dove erano già stati scompigliati dai tori. Lo riconobbe don Chisciotte, e disse a Sancio: «Il prato è questo dove noi c'incontrammo colle bizzarre pastorelle e coi pastori galanti che volevano rinnovare e imitare la pastorale Arcadia: pensiero nuovo altrettanto quanto prudente, ed a cui imitazione io vorrei, o Sancio, se tu approvi il divisamento, che noi ci convertissimo in pastori per tutto il tempo in cui sarò obbligato al ritiro. Io comprerò alquante pecore e le altre cose tutte che al pastorale esercizio son necessarie; mi chiamerò il pastore Chisciotizzo e tu il pastore Pancino, e ce ne andremo per i monti, per le selve e per i prati, qui cantando, querelandoci là, bevendo le onde dei liquidi cristalli delle fonti o dei limpidi ruscelli ovvero dei rapidi fiumi. Ci somministreranno le querce a larga mano le dolcissime loro frutta; ci serviranno di sedia i tronchi dei durissimi sugheri, di ombra i salici, di odore le rose e di tappeti gli spaziosi campi di mille colori dipinti. Sarà nostro alito l'aria chiara e pura; saranno luce la luna e le stelle a dispetto dell'oscurità della notte; avremo allegrezza nel gaudio e nel pianto, e c'inspirerà Apollo i versi e gli amorosi concetti coi quali potremo renderci famosi non pure nei secoli presenti, ma nei futuri. — Perdinci, rispose Sancio, che questa maniera di vita sarebbe uno zucchero, e mi andrebbe proprio proprio a sangue; e scommetterei che il baccelliere Carrasco e maestro Nicolò barbiere, non l'avranno saputo appena, che verrà loro la frega di seguitarla e di farsi eglino ancora pastori con noi: e chi sa che non venga il grillo anche al signor curato di entrare nel branco, ch'egli è uomo di allegro umore e molto amico di darsi bel tempo. — Tu hai detto benissimo, soggiunse don Chisciotte, e il baccelliere Sansone Carrasco se entrerà nel pastorale grembo (ché vi entrerà senza dubbio), potremo chiamarlo il pastore Sansonino o il pastore Carrascone. Nicolò barbiere potrà intitolarsi Niccoloso, come già l'antico Boscano si chiamò Nemoroso; non so che nome daremo al curato, se non fosse alcuno derivativo dal suo appellandolo il pastore Curatambro. In riguardo alle pastorelle delle quali dovremo essere seguaci, potremo, come in una cesta di pere, scegliere i loro nomi: e giacché quello della mia signora tanto quadra a pastorella come a principessa, non occorre che io vada a dicervellarmi per cercarne altro che meglio le si convenga: tu, o Sancio, porrai poi alla tua il nome che più ti andrà a genio. — Io fo conto, disse Sancio, di non metterle altri nomi che quello di Teresona, che calzerà bene colla sua grassezza; e molto più che celebrandola io nei miei casti desiderii, non andando a cercare miglior pane che di grano per le case altrui; né sarà poi bene che il curato tenga pastora, come colui che ci deve dar buon esempio; e se il baccelliere vorrà averne una, ci pensi egli. — Poffare il mondo! disse don Chisciotte, che vita abbiamo a condurre noi, Sancio amico! Quante zampogne ci hanno da rallegrare gli orecchi, quante pive zamorane, quanti tamburini, quante sonagliere, quanti ribecchini! Pensa poi se tra questa diversità di musica ci sarà frammischiata quella degli alboghi! Oh si avranno tra noi quasi tutti i pastorali strumenti. — Che cosa sono questi alboghi? disse Sancio, ché io non li ho sentiti mai a nominare, né li ho visti mai in vita mia. — Gli alboghi, rispose don Chisciotte, sono certe piastre come di candelliere d'ottone, che dando una contro l'altra, per lo vôto e vano mandano suono se non molto grato ed armonico, almeno che non dispiace e si accorda colla rusticità della piva e del tamburino. Albogo è vocabolo moresco, come lo sono tutti quelli che nella lingua castigliana cominciano in al; per esempio: almohaza, almozar, alhambra, alguázil, alhuzema, alcuza, almazen, alcanzia, ed altri somiglianti, che debbono essere pochi più: e tre soltanto ne ha la lingua spagnuola che sono moreschi e terminano in i, e sono: borcegui, zaguizami, maravedi: le voci alheli e alfaqui, tanto dall'al onde cominciano, quanto dall'i in cui finiscono, sono conosciute per arabiche. Ti ho detto questo di passaggio e per essermelo ricordato nella occasione di nominare alboghi; e ci ha da giovare assai alla perfezione di questo esercizio l'essere io un cotal poco poeta, come tu sai, e come lo è ancora in grado eccellente il baccelliere Sansone Carrasco: del curato non fo parole, ma scommetterei ch'egli pure non debba avere i suoi merletti ed il collare da poeta, come non dubito che li avrà maestro Niccolò; perché tutti o la maggior parte dei barbieri sono poetastri o chitarristi. Io mi dorrò della lontananza; tu ti vanterai d'innamorato costante; il pastore Carrascone d'essere disprezzato, e il curato Cutacambro di quello che più gli sarà in piacere, ed in tal maniera procederà benissimo la nostra vita.» Sancio rispose: — Signore e mio padrone, io sono tanto disgraziato che ho paura non arriverà mai quel giorno in cui mi vegga in questo beato posto. Che bei cucchiai farei io quando fossi pastore! Quanti pani grattati! Quanti pastorali manicaretti! Rinunzierei allora alla fama di savio, e mi contenterei di quella di grazioso; e Sancetta, mia figliuola, porterebbe da mangiare al gregge: ma attenti bene, ché Sancetta è belluccia, e vi hanno pastori più maliziosi che semplici, né vorrei che andasse per lane, e tornasse tosata; ché nelle campagne come nelle città vi si pecca; e levata la causa, si leva il peccato; e occhio che non vede, cuore non crede; ed è meglio essere uccello di campagna, che di gabbia. — Basta, basta, non più proverbi, o Sancio, disse don Chisciotte, che qualsivoglia di quelli che hai detto basta per esprimere il tuo pensiero. Ti ho consigliato le tante volte a non voler essere sì prodigo di strambotti, ma e' mi pare di aver predicato al deserto, e come diceva quella buona donna: Forbice, forbice. — Mi sembra, rispose Sancio, che vossignoria sia come quello che si suole dire, che la padella ha detto al paiuolo: Fatti in là, ché tu mi tingi; ella mi sta correggendo perché mi astenga dal dire proverbi, e intanto vossignoria li va infilzando a due per due. — Considera, o Sancio, rispose don Chisciotte, che io fo uso dei proverbi a proposito, e calzano a pennello quando io li dico: ma tu li strascichi tanto, che escono fuori di tempo e non in via naturale. Mi ricordo di averti detto altra volta che i proverbi sono sentenze brevi, cavate dalla sperienza e dalle speculazioni dei nostri antichi saggi, e che il proverbio ch'esce senza occasione, è piuttosto sproposito che sentenza. Ma di ciò non si parli più: e giacché si avvicina la sera, appartiamoci alquanto dalla strada maestra, e cerchiamo dove passare la notte, ché dimani Dio sa quello che sarà.» Si ritirarono, cenarono tardi e male, e ognuno pensi che ciò seguiva contro la intenzione di Sancio, il quale si ricordava tutte le angustie della errante cavalleria incontrate nelle selve e nei monti, che però vedeva talvolta temperate coll'abbondanza trovata nei castelli e nelle abitazioni sì di don Diego di Miranda, come nelle nozze del ricco Camaccio ed in casa di don Antonio Moreno. Considerando non essere possibile che sia sempre di giorno, né sempre di notte, si addormentò finalmente, lasciando in piena veglia il padrone. La notte era alquanto buia, benché la luna fosse in cielo; ma si trovava in sito da non poter essere veduta, perché la dea Diana se ne va talvolta a passeggiare agli antipodi, e lascia neri i monti e oscure le valli. Servì don Chisciotte alla natura, dormendo il primo sonno, che non fu però seguitato dal secondo, tutto al contrario di Sancio, che non fece mai un secondo sonno, perché cominciava la sera per finire la mattina: dal che conoscevansi e la buona complessione e i suoi pochi pensieri. Quelli che occuparono don Chisciotte furono tali da indurlo a svegliar Sancio, ed a dirgli: — Io resto stupito della indole di tua natura, o Sancio, e mi figuro che tu sii fatto di marmo o di bronzo che non ha movimento né senso alcuno: io veglio mentre tu dormi, io piango quando tu ridi, io svengo per lo digiuno, quando tu te ne stai a panciolle e senza far nulla per avere pieno il ventre; ma non sai che debbono i buoni e amorosi servi togliere sopra di loro le pene dei padroni, almeno perché si dice che hanno buon cuore? Guarda adesso la serenità di questa notte e la solitudine in cui ci troviamo, la quale c'invita a frapporre qualche veglia al nostro sonno: levati, per la vita tua, e scostati di qua un cotal poco, e con buon animo e con gradito ardire affibiati tre o quattrocento frustate a buon conto per le occorrenti per lo disincanto di Dulcinea. Te ne prego, te ne supplico, ché non vorrei più far teco alle braccia come altra volta, mentre so quanto pesano. Quando ti sarai ben bene frustato, passeremo il resto della notte cantando, io la mia assenza e tu il tuo coraggio, e daremo tosto principio al pastorale esercizio che dovrà diventare la gradita nostra occupazione. — Padrone mio, rispose Sancio, io non sono frate che mi abbia a svegliare sul bel mezzo del sonno per disciplinarmi, né manco mi pare che dall'estremo dolore delle frustate si possa passare in un attimo a cantare di musica: mi lasci vossignoria a dormire e non mi stia a sollecitare altro di frustarmi, ché giuro sull'anima mia che non vorrei ora torcermi né anche un pelo della casacca. — Ah, anima indurita! sclamò don Chisciotte, scudiere senza pietà, pane mal impiegato, mercedi mal valutate e quello che avesti, e quello che avevo pensato di darti! In grazia mia ti sei visto governatore, in grazia mia ti trovi con vicina speranza di essere conte o di tenere altro equivalente titolo, e non tarderà a passare quest'anno, ché io post tenebras spero lucem! — Io non intendo niente di questo, disse Sancio, e intendo solo che fino a tanto che dormo non sento né timore, né speranza, né travaglio, né gloria: che benedetto sia pure chi inventò il sonno, cappa che copre tutti gli umani pensieri, cibo che toglie la fame, acqua che estingue la sete, fuoco per cui fugge il freddo, freddo che tempra l'ardore, moneta generale con cui tutto si compra, bilancia e peso che rende eguale il re al pastore ed il saggio allo zotico: no, il sonno non ha in sé altro di cattivo, da quanto ho inteso dire più volte, se non che rassomiglia alla morte, passando poca differenza da uomo morto ad addormentato. — Non ti ho sentito mai, o Sancio, disse don Chisciotte, a parlare con tanta eleganza come adesso, e vengo a comprendere essere vero il tuo proverbio: Non con chi tu nasci, ma con chi tu pasci. — Oh, corpo del diavolo! replicò Sancio, non sono poi io quello che infilza proverbi, ché anche alla signoria vostra snocciolano fuori di bocca a coppie meglio che a me, e non vi è altra differenza tra i miei ed i suoi se non che quelli di vossignoria sono buttati là a tempo, ed i miei fuori di stagione, ma poi sono tutti proverbi.» In questa guisa continuava il dialogo, quando s'intese ad un tratto sordo fracasso e noioso rumore che per tutte quelli valli si distendeva. Rizzossi don Chisciotte, e pose mano alla spada, e Sancio si rannicchiò sotto al leardo, mettendosi ai fianchi il fagotto delle armi e la bardella del suo giumento, e tremando tutto di paura. Non restò senza perturbarsi né anche don Chisciotte per lo rombazzo che veniva crescendo e appressandosi. Ora avvenne che certi uomini menando a vendere ad un mercato più di seicento porci, con essi a quell'ora avanzavano cammino, ed era il rumore causato dal degrignare e dallo stridere che facevano quegli animali, e con cui assordavano gli orecchi di don Chisciotte e di Sancio senzaché potessero capire che cosa si fosse. Arrivò in truppa il gregge grugnitore, e senza portar rispetto all'autorità del valoroso don Chisciotte, passò di sopra ad esso ed a Sancio, disfacendo le trincee e facendo cadere tutto ad un fiato e don Chisciotte ed anche il suo Ronzinante. Il gran numero, il grugnire e la prestezza con cui arrivarono quegl'immondi animali, produssero estrema confusione, gittando sottosopra la bardella, le armi, il leardo, Ronzinante, Sancio e don Chisciotte. Si rizzò Sancio alla meglio, ed infuriato dimandò la spada al padrone, dicendogli che voleva ammazzare una dozzina di quei signori e malcreati porci, che già li aveva benissimo conosciuti. Don Chisciotte gli disse: — Lasciali andare, amico, che questo affronto è pena del mio peccato, ed è giusto castigo del Cielo che un cavaliere errante abbattuto sia mangiato dal gavocciolo, punto dalle vespe, calpestato dai porci. — Deve pure, Sancio rispose, essere castigo del Cielo che gli scudieri dei vinti cavalieri erranti siano dalle mosche punzecchiati, mangiati dagl'insetti e investiti dalla fame? Se gli scudieri fossero figliuoli dei cavalieri ai quali servono, o loro prossimi parenti, non ci sarebbe che dire quando li colpisse la pena dei falli sino alla quarta generazione: ma che hanno mai a fare i Pancia con i Chisciotti? Basta, torniamoci a coricare, e dormiamo il poco che rimane della notte; ché domani qualche santo ci aiuterà. — Dormi tu, o Sancio, rispose don Chisciotte, tu che sei nato per dormire, quando io nacqui per vegliare. Nel poco di tempo che manca sino all'alba, io lascerò libero il corso ai miei pensieri, e li sfogherò in un madrigaletto, che composi stanotte nella mia fantasia senza farne teco parola. — Pare a me, rispose Sancio, che i pensieri che possono esprimersi in versi non debbano essere molto seri, ma vossignoria versifichi pure a suo piacere, ché intanto io dormirò il meglio che potrò.» E sdraiandosi sulla terra, si accoccolò e tornò a dormire saporitamente senzaché mallevadorie, debiti o dolore alcuno ne lo sturbassero. Don Chisciotte, appoggiato al tronco di un faggio o sughero (ché Cide Hamete Ben-Engeli non ha distinto bene di che qualità fosse l'albero), cantò al suono dei suoi stessi sospiri i versi seguenti:
Accompagnato era da molti gemiti e da non poche lagrime ognuno di questi versi, come parto di un cuore trafitto dal cruccio dell'essere stato vinto e da quello dell'assenza di Dulcinea. Venne il giorno, ed il sole colpì co' suoi raggi gli occhi di Sancio, che si destò, si stirò, e scuotendo e dilungando le infingarde membra, mirò il mal governo che avevano fatto i porci della sua credenza, e maledisse il gregge, e andò anche più avanti colle imprecazioni. Tornarono finalmente ambidue all'intrapreso cammino, e al declinare del giorno si accorsero che venivano alla volta loro intorno a dieci uomini a cavallo, e quattro o cinque a piedi. Si destò il coraggio a don Chisciotte, e si avvilì quello di Sancio, perché quella gente portava lance e targhe, e sembrava disposta a combattere. Don Chisciotte si voltò a Sancio e gli disse: — Se io potessi, o Sancio, trattare le armi, e non fossi sì legato nelle braccia della mia fede, io valuterei meno di uno zero le nuove diavolerie che ci minacciano: ma potrebbe anche essere che fosse altra cosa differente da quella che noi temiamo.» Giunsero in quell'istante due di quelli a cavallo, e inalberando le lance, senza dir parole circondarono don Chisciotte, e gliele appuntarono alle spalle ed al petto, minacciando di volerlo ammazzare. Uno di quelli a piedi si avvicinò un dito alla bocca in segno che ciascuno dovesse osservare il silenzio, pigliò Ronzinante per la briglia e lo tirò fuori di strada; gli altri a piedi cacciaronsi dinanzi Sancio e il leardo, e serbando ognuno alto e costante silenzio, seguitò i passi di colui che menava don Chisciotte, il quale due o tre volte tentò di chiedere dove lo conducessero o quello che da lui si pretendesse. Ma cominciava egli appena a movere le labbra, e tosto erano pronte a chiuderle i ferri delle lance; e lo stesso avveniva a Sancio subito che faceva mostra di voler parlare: ed uno di quei pedoni punzecchiava con un pungolo lui e il leardo ancora, come se anche questo desse intenzione di voler parlare. Venne la notte, accelerando il passo, crebbe la paura nei due prigioni, e più ancora quando udirono che di tanto in tanto dicevasi loro: — Camminate, trogloditi; tacete, barbari; pagate, antropofaghi; non vi lagnate, sciti; non aprite gli occhi, Polifemi ammazzatori, leoni divoratori;» ed altri nomi simili a questi coi quali tormentavano l'udito dei miserabili padrone e servitore. Andava Sancio fra sé dicendo: — A noi tortoliti? a noi barbieri, a noi troppo fango! Eh, non mi piacciono per niente questi titoli; tira un cattivo vento a quest'aia: tutto il male viene in una volta come al cane le bastonate, e volesse Dio che fossero almeno le ultime tra tante nostre sventurate venture.»
— Mi aiuti il Cielo! diss'egli come l'ebbe meglio riconosciuto: che sarà mai? Non è questa la casa della cortesia e della buona creanza? Ma per i vinti il bene si converte in male e il male in peggio.» Entrarono nell'andito principale del castello, e lo videro preparato e disposto in maniera che si accrebbe in loro la meraviglia, e si raddoppiò la paura, come si vedrà nel capitolo seguente. |

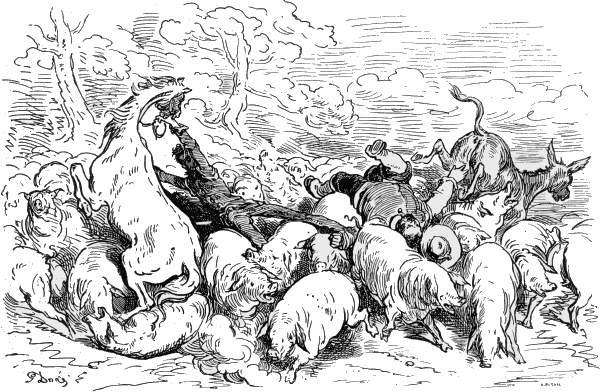
 Don
Chisciotte marciava come un uomo mezzo fuori di sé e senza cogliere nel segno, per quanti
ragionamenti facesse a fine di conoscere la causa che l'esponeva a tanti oltraggi, dai
quali in sostanza veniva a conchiudere ch'ei non poteva sperar nulla di bene. Pervennero
quasi ad un'ora di notte in un castello, che fu conosciuto da don Chisciotte per quello
del duca, da dove non era molto che aveva fatto partenza.
Don
Chisciotte marciava come un uomo mezzo fuori di sé e senza cogliere nel segno, per quanti
ragionamenti facesse a fine di conoscere la causa che l'esponeva a tanti oltraggi, dai
quali in sostanza veniva a conchiudere ch'ei non poteva sperar nulla di bene. Pervennero
quasi ad un'ora di notte in un castello, che fu conosciuto da don Chisciotte per quello
del duca, da dove non era molto che aveva fatto partenza.